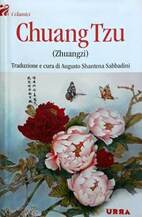Letture
|
Svariati studiosi di storia delle religioni ritengono che il Taoismo sia la meno conosciuta fra le religioni nel mondo e, forse, molti metterebbero anche in dubbio che si tratti davvero di una religione, dato che tanto esile è il suo corpus dogmatico costituitosi nel corso del tempo. In ogni caso due testi sono considerati unanimemente come i riferimenti indispensabili per questa dottrina: il Daodejing, o Tao Te Ching «Libro della Via e della Virtù», che è un testo cinese in prosa talvolta rimata, la cui composizione risale a un periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C.; il Zhuāngzǐ, o Chuang-tzu, che fu un filosofo e mistico cinese e che viene considerato come autore del testo stesso. |
Il Chuang-tzu è probabilmente il testo mistico al quale amo di più tornare: l’ho letto e riletto, come bisognerebbe fare per ogni grande classico in epoche differenti della vita e, ogni volta, si rivela come una scoperta e un’avventura inesauribile.
Mi sono anche chiesto la possibile ragione di questa predilezione: il Tao Te Ching è certo, per altri versi, più scabro ed essenziale, con uno stile che potremmo definire senz’altro aforistico e, bisogna anche ammettere che, rispetto ai punti determinanti della dottrina, per ogni concetto di fondo del Chuang-tzu si può individuare la traccia corrispondente nel Tao Te Ching.
Eppure il mio incanto di fronte a questa opera rimane immutato: si tratta di una predilezione spontanea, di una affinità intuitiva che va oltre qualsiasi argomentazione.
Lo Zhuāngzǐ è considerato portatore di una raffinata poetica e, in quest’opera, la lingua cinese viene utilizzata in differenti modi che ne rivelano le infinite sfaccettature.
Questo, ovviamente, rende il testo di ardua traduzione; numerose ormai sono quelle in lingua inglese, mentre in italiano attualmente sono disponibili tre traduzioni diverse, ma condotte direttamente sul testo cinese.
Il lettore interessato potrebbe iniziare semplicemente col confrontare le diverse traduzioni del medesimo passaggio per rendersi immediatamente conto di una grande verità, cioè di come ogni traduzione sia in sé un’interpretazione, assioma questo che il Chuang-tzu conferma nel miglior dei modi.
Personalmente, avendo utilizzato le tre traduzioni, mi sentirei di consigliare questa: Chuang-tzu, (Zhuang-zi) traduzione e cura di Augusto Shantena Sabbadini, Milano, Urra, 2012. ISBN 978-88-503-3172-7.
Il traduttore ha premesso una valida introduzione, rigorosa dal punto di vista filologico e che però non risulta mai pesante né eccessivamente erudita: in essa fa davvero il punto sullo stato attuale degli studi intorno a quest’opera, chiarendo bene la posizione filologicamente più autorevole, quella di A.C. Graham.
Proprio dalla sua posizione vorrei sviluppare alcune considerazioni intorno al fascino che per me emana da questo testo.
L'opera si presenta come composta da trentatré capitoli: i primi sette capitoli sono detti nèipiān ("capitoli interni"), i successivi quindici capitoli sono detti wàipiān ("capitoli esterni"), mentre gli undici ultimi capitoli sono denominati come zápiān ("capitoli misti").
È quasi impossibile che questi capitoli possano provenire da un’unica fonte: su questo punto concordano tutti gli studiosi, sulle base di complesse ragioni sia di ordine filologico sia semantico, cui non cerchiamo neanche di accennare, ma che il lettore troverà discusse con precisione nella traduzione che ho indicato. La loro collocazione in un unico testo è generalmente attribuita a una delle guide del movimento neodaoista Guō Xiàng (forse 312 d.C.).
L'analisi condotta sul testo dai vari studiosi porta a concludere che generalmente i primi capitoli si dimostrano i più brillanti ed esaurienti rispetto alla dottrina del Taoismo e che sono forse quelli di più antica stesura. I restanti capitoli, anche se contengono dei brani altrettanto suggestivi e profondi risultano più prolissi e, a volte, sembrano piuttosto essere dei commentari dei capitoli interni. Altri ancora, come il trentatreesimo che, in realtà, riesce a condurre un’analisi complessiva delle sei differenti scuola filosofiche esistenti in Cina, sono certamente opera di uno o più autori non antecedenti al periodo in cui visse Guō Xiàng, e forse sono scritti proprio da questo autore storicamente collocabile.
Raccogliendo le indicazioni già presenti in studiosi precedenti, Graham non fa che precisare meglio, sulla base di considerazioni filologicamente sostenute e condivisibili, i contenuti presenti in tutti i capitoli, arrivando a proporre interpretazioni delle tendenze filosofiche alle quali essi possono venire ricondotti.
A mio avviso emerge dalla lettura diretta del testo, supportata dalle considerazioni che prima ho brevemente ricordato, che il Chuang-tzu è, come la maggioranza dei testi classici, un’opera collettiva. Cosi è, per esempio, nel caso delle Upaniṣad e dei Veda, oppure della Iliade e dell’Odissea in ambito classico o di tanti altri testi fondativi di tradizioni religiose o culturali. Questo ovviamente non esclude che sia storicamente esistito un autore di nome Chuang-tzu, non diversamente da come potrebbe essere esistito il nostro cantore cieco, oppure, in entrambi i casi, l’esistenza di un personaggio leggendario potrebbe anche avere un fondamento storico e tuttavia risulta difficile credere che possa essere stato l’autore di questa complessità variegata di testi.
L’ipotesi più probabile è, a mio avviso, questa che, a partire da un nocciolo originario, per quanto difficilmente precisabile in base alle nostre attuali conoscenze, tale nucleo è
andato, nel corso delle generazioni e dei secoli, progressivamente crescendo, in modo naturale, come un fiume cresce con l’apporto continuo dei suoi affluenti.
Esisteva già il nocciolo del Chuang-tzu: la sua evidenza e la sua rappresentatività ebbero come effetto naturale che pensatori e scrittori anche differenti per temperamento e ascendenze culturali trovassero preferibile riversare la loro riflessione e la loro produzione in questo grande contenitore ricco di potenzialità.
Su questo punto occorre forse insistere e spendere ancora qualche precisazione: non intendo sostenere che questi scrittori procedessero in questo modo per una sorta di calcolo, cioè che volentieri iscrivessero i testi da loro redatti per acquisirne una diretta rilevanza, un avallo che ponesse la loro opera al riparo da ogni perplessità; piuttosto ritengo che in modo naturale preferissero riconoscere se stessi come eredi di questa profonda tradizione, piuttosto che rivendicare in senso egoistico la loro personale figura di scrittori.
Questa tesi mi conduce a valutare in modo negativo la tendenza contraria, attiva ed ormai direi egemone nella nostra presente epoca: essa insiste sul valore preponderante dell’individuo, tesse gli elogi impliciti della originalità delle idee da lui sostenute, mentre, ad una analisi attenta, risulta evidente che l’originalità non è certo un valore in sé e, infine, che in tanta produzione e scrittura attuali di veramente nuovo non c’è niente e che si tratta di qualche idea perennemente riciclata con scarsi apporti creativi.
Quando ci troviamo di fronte a un testo che appartiene davvero a una tradizione spirituale, mi sento di dichiarare che la presunta originalità delle idee, in verità, non esiste e che, se anche esistesse, non andrebbe tenuta in nessun conto: ciò che costituisce lo spessore di un testo spirituale non è certo un’idea astratta, ma solo il contenuto concreto di vita che una persona ci ha riversato nel corso della sua esperienza vissuta.
Leggendo e rileggendo il Chuang-tzu sento viva e palpitante questa esperienza – e mi commuove il fatto che il singolo autore, spontaneamente, non intende rivendicarla per sé, come frutto di un proprio presunto talento naturale, ma preferisce iscrivere questa esperienza nel solco di una tradizione spirituale già esistente e consolidata; questo avvenne, lo ripeto, non per evitare degli ostacoli, ma per profonda umiltà.
Questa scelta conferma che, in fondo, di fronte alle autentiche opere dello Spirito, ben poca importanza hanno le circostanze specifiche della propria singola esistenza, mentre essenziale è essere venuti in contatto con un Maestro, con una tradizione vivente, con una vera scuola di Vita, in cui la scrittura ha potuto germinare e crescere e nella cui corrente volentieri il singolo autore lo riversa e infine lo affida con una superiore fiducia.
(Sergio Gandini)
Mi sono anche chiesto la possibile ragione di questa predilezione: il Tao Te Ching è certo, per altri versi, più scabro ed essenziale, con uno stile che potremmo definire senz’altro aforistico e, bisogna anche ammettere che, rispetto ai punti determinanti della dottrina, per ogni concetto di fondo del Chuang-tzu si può individuare la traccia corrispondente nel Tao Te Ching.
Eppure il mio incanto di fronte a questa opera rimane immutato: si tratta di una predilezione spontanea, di una affinità intuitiva che va oltre qualsiasi argomentazione.
Lo Zhuāngzǐ è considerato portatore di una raffinata poetica e, in quest’opera, la lingua cinese viene utilizzata in differenti modi che ne rivelano le infinite sfaccettature.
Questo, ovviamente, rende il testo di ardua traduzione; numerose ormai sono quelle in lingua inglese, mentre in italiano attualmente sono disponibili tre traduzioni diverse, ma condotte direttamente sul testo cinese.
Il lettore interessato potrebbe iniziare semplicemente col confrontare le diverse traduzioni del medesimo passaggio per rendersi immediatamente conto di una grande verità, cioè di come ogni traduzione sia in sé un’interpretazione, assioma questo che il Chuang-tzu conferma nel miglior dei modi.
Personalmente, avendo utilizzato le tre traduzioni, mi sentirei di consigliare questa: Chuang-tzu, (Zhuang-zi) traduzione e cura di Augusto Shantena Sabbadini, Milano, Urra, 2012. ISBN 978-88-503-3172-7.
Il traduttore ha premesso una valida introduzione, rigorosa dal punto di vista filologico e che però non risulta mai pesante né eccessivamente erudita: in essa fa davvero il punto sullo stato attuale degli studi intorno a quest’opera, chiarendo bene la posizione filologicamente più autorevole, quella di A.C. Graham.
Proprio dalla sua posizione vorrei sviluppare alcune considerazioni intorno al fascino che per me emana da questo testo.
L'opera si presenta come composta da trentatré capitoli: i primi sette capitoli sono detti nèipiān ("capitoli interni"), i successivi quindici capitoli sono detti wàipiān ("capitoli esterni"), mentre gli undici ultimi capitoli sono denominati come zápiān ("capitoli misti").
È quasi impossibile che questi capitoli possano provenire da un’unica fonte: su questo punto concordano tutti gli studiosi, sulle base di complesse ragioni sia di ordine filologico sia semantico, cui non cerchiamo neanche di accennare, ma che il lettore troverà discusse con precisione nella traduzione che ho indicato. La loro collocazione in un unico testo è generalmente attribuita a una delle guide del movimento neodaoista Guō Xiàng (forse 312 d.C.).
L'analisi condotta sul testo dai vari studiosi porta a concludere che generalmente i primi capitoli si dimostrano i più brillanti ed esaurienti rispetto alla dottrina del Taoismo e che sono forse quelli di più antica stesura. I restanti capitoli, anche se contengono dei brani altrettanto suggestivi e profondi risultano più prolissi e, a volte, sembrano piuttosto essere dei commentari dei capitoli interni. Altri ancora, come il trentatreesimo che, in realtà, riesce a condurre un’analisi complessiva delle sei differenti scuola filosofiche esistenti in Cina, sono certamente opera di uno o più autori non antecedenti al periodo in cui visse Guō Xiàng, e forse sono scritti proprio da questo autore storicamente collocabile.
Raccogliendo le indicazioni già presenti in studiosi precedenti, Graham non fa che precisare meglio, sulla base di considerazioni filologicamente sostenute e condivisibili, i contenuti presenti in tutti i capitoli, arrivando a proporre interpretazioni delle tendenze filosofiche alle quali essi possono venire ricondotti.
A mio avviso emerge dalla lettura diretta del testo, supportata dalle considerazioni che prima ho brevemente ricordato, che il Chuang-tzu è, come la maggioranza dei testi classici, un’opera collettiva. Cosi è, per esempio, nel caso delle Upaniṣad e dei Veda, oppure della Iliade e dell’Odissea in ambito classico o di tanti altri testi fondativi di tradizioni religiose o culturali. Questo ovviamente non esclude che sia storicamente esistito un autore di nome Chuang-tzu, non diversamente da come potrebbe essere esistito il nostro cantore cieco, oppure, in entrambi i casi, l’esistenza di un personaggio leggendario potrebbe anche avere un fondamento storico e tuttavia risulta difficile credere che possa essere stato l’autore di questa complessità variegata di testi.
L’ipotesi più probabile è, a mio avviso, questa che, a partire da un nocciolo originario, per quanto difficilmente precisabile in base alle nostre attuali conoscenze, tale nucleo è
andato, nel corso delle generazioni e dei secoli, progressivamente crescendo, in modo naturale, come un fiume cresce con l’apporto continuo dei suoi affluenti.
Esisteva già il nocciolo del Chuang-tzu: la sua evidenza e la sua rappresentatività ebbero come effetto naturale che pensatori e scrittori anche differenti per temperamento e ascendenze culturali trovassero preferibile riversare la loro riflessione e la loro produzione in questo grande contenitore ricco di potenzialità.
Su questo punto occorre forse insistere e spendere ancora qualche precisazione: non intendo sostenere che questi scrittori procedessero in questo modo per una sorta di calcolo, cioè che volentieri iscrivessero i testi da loro redatti per acquisirne una diretta rilevanza, un avallo che ponesse la loro opera al riparo da ogni perplessità; piuttosto ritengo che in modo naturale preferissero riconoscere se stessi come eredi di questa profonda tradizione, piuttosto che rivendicare in senso egoistico la loro personale figura di scrittori.
Questa tesi mi conduce a valutare in modo negativo la tendenza contraria, attiva ed ormai direi egemone nella nostra presente epoca: essa insiste sul valore preponderante dell’individuo, tesse gli elogi impliciti della originalità delle idee da lui sostenute, mentre, ad una analisi attenta, risulta evidente che l’originalità non è certo un valore in sé e, infine, che in tanta produzione e scrittura attuali di veramente nuovo non c’è niente e che si tratta di qualche idea perennemente riciclata con scarsi apporti creativi.
Quando ci troviamo di fronte a un testo che appartiene davvero a una tradizione spirituale, mi sento di dichiarare che la presunta originalità delle idee, in verità, non esiste e che, se anche esistesse, non andrebbe tenuta in nessun conto: ciò che costituisce lo spessore di un testo spirituale non è certo un’idea astratta, ma solo il contenuto concreto di vita che una persona ci ha riversato nel corso della sua esperienza vissuta.
Leggendo e rileggendo il Chuang-tzu sento viva e palpitante questa esperienza – e mi commuove il fatto che il singolo autore, spontaneamente, non intende rivendicarla per sé, come frutto di un proprio presunto talento naturale, ma preferisce iscrivere questa esperienza nel solco di una tradizione spirituale già esistente e consolidata; questo avvenne, lo ripeto, non per evitare degli ostacoli, ma per profonda umiltà.
Questa scelta conferma che, in fondo, di fronte alle autentiche opere dello Spirito, ben poca importanza hanno le circostanze specifiche della propria singola esistenza, mentre essenziale è essere venuti in contatto con un Maestro, con una tradizione vivente, con una vera scuola di Vita, in cui la scrittura ha potuto germinare e crescere e nella cui corrente volentieri il singolo autore lo riversa e infine lo affida con una superiore fiducia.
(Sergio Gandini)